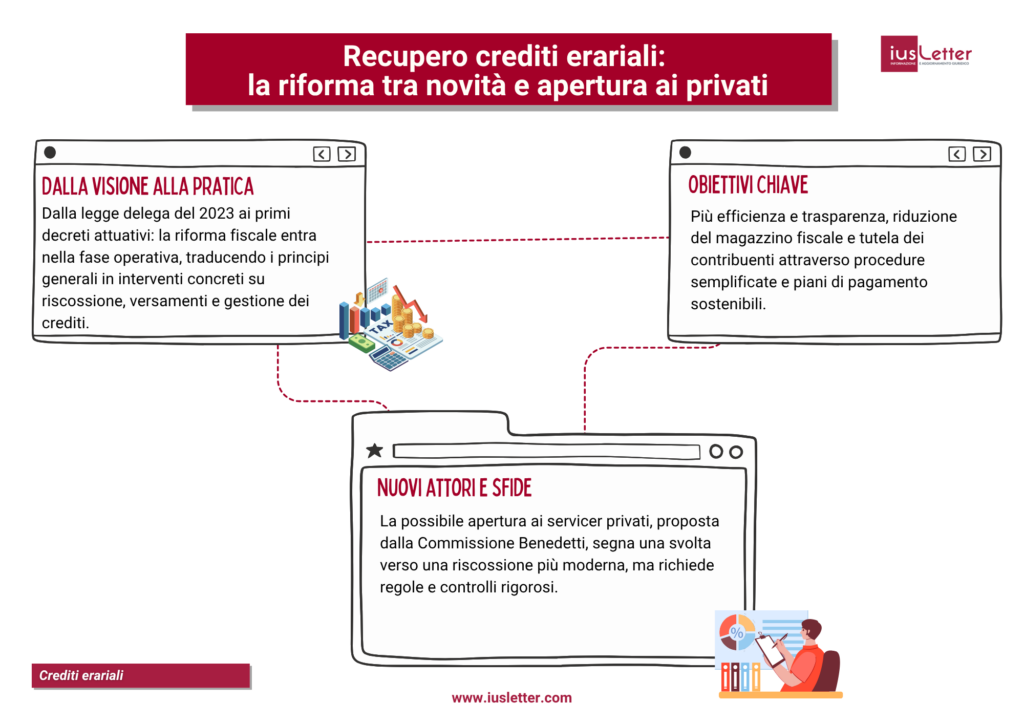
Il recupero dei crediti erariali costituisce da anni una delle criticità più rilevanti del sistema fiscale italiano. A fronte di carichi affidati superiori a 1.880 miliardi di euro dal 2000 al 2025, il “magazzino fiscale” residuo ammonta, ad oggi, a circa 1.280 miliardi, di cui una quota rilevante è da considerarsi non più esigibile o di difficile riscossione.
Il nodo del magazzino fiscale
L’ammontare contabile dei crediti residui iscritti a ruolo è ingente, ma le effettive possibilità di recupero sono molto più limitate. Infatti, oltre un terzo appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (149 miliardi riguardano soggetti interessati da procedure concorsuali, 224 miliardi sono riferiti a contribuenti deceduti e imprese cessate e 139 miliardi sono relativi a soggetti nullatenenti), a questo si aggiungono 88,7 miliardi interessati da specifici provvedimenti di sospensione o rateizzazioni in corso (ad esempio “Rottamazione quater”) e 581 miliardi relativi a contribuenti nei confronti dei quali sono già state svolte azioni esecutive/cautelari. Quindi, solo 101 miliardi potrebbero essere oggetto di azioni di recupero future, ma con possibili ostacoli normativi e pratici.
La cornice normativa: dalla legge delega ai decreti attuativi.
Il tema è tornato al centro dell’agenda politica con la Legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, che ha dato avvio a una delle più ampie riforme fiscali degli ultimi decenni. La delega ha affidato al Governo il compito di riscrivere il sistema tributario secondo criteri di semplificazione, riduzione della pressione fiscale e riequilibrio del rapporto fisco-contribuente.
Diciannove i decreti attuativi esaminati, sedici già approvati. Tra questi particolarmente rilevante è il D.lgs. n. 110/2024, in vigore dall’8 agosto 2024, che rappresenta il cuore della riforma in materia di riscossione coattiva. Il decreto introduce una pianificazione annuale dell’attività di riscossione condivisa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate-Riscossione ed enti locali, un discarico automatico dei carichi non riscossi entro cinque anni, una interazione dei vari sistemi informatici per semplificare la gestione dei crediti e una revisione delle regole di impugnabilità di ruolo e cartella per ridurre il contenzioso pretestuoso.
Elemento centrale è anche l’istituzione, avvenuta con decreto ministeriale del 30 ottobre 2024, della Commissione per il riordino della riscossione, presieduta da Roberto Benedetti, già presidente di sezione della Corte dei Conti, incaricata di analizzare e proporre soluzioni per il progressivo smaltimento del magazzino crediti.
Inoltre, la legge delega all’art. 21 ha incaricato il Governo di adottare uno o più decreti legislativi volti al riordino della legislazione tributaria mediante la redazione di testi unici. Allo stato cinque sono gli schemi di decreto legislativo per i quali è stato concluso l’iter parlamentare.
Sul punto, meritevole di menzione è il Decreto Legislativo n. 33/2025, quale “Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione” che, seppur entrato in vigore il 27 marzo 2025, troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2026. Tale Testo non prevede novità normative ma nasce dall’esigenza di razionalizzare e accorpare le numerose disposizioni legislative finora frammentate in materia di versamenti fiscali, contributivi e riscossione coattiva, con l’obiettivo di semplificare il quadro normativo, migliorare l’efficienza degli enti riscossori e favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
In sintesi, la riforma fiscale ha ormai preso forma concreta: dalla cornice di principi generali si passa a un sistema operativo fondato su trasparenza, efficienza e sostenibilità, in cui la gestione del credito erariale diventa un tassello strategico per la finanza pubblica.
Verso una nuova stagione della riscossione: il DDL n. 1375 e le proposte della Commissione Benedetti
È attualmente in corso presso la Commissione Finanze del Senato, l’esame del Disegno di legge n. 1375, recante “Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all’agente della riscossione”. Il provvedimento si inserisce nel percorso di riforma organica della riscossione avviato dalla legge delega n.111 del 2023, con l’obiettivo di introdurre maggiore flessibilità per i contribuenti e al tempo stesso razionalizzare la gestione del cosiddetto magazzino fiscale, che ricordiamo rappresenta l’insieme dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) e non ancora riscossi.
Il disegno di legge prevede la possibilità per i contribuenti, in temporanea difficoltà economico-finanziaria, di ottenere piani di dilazione fino a 120 rate mensili, equivalenti a dieci anni, e introduce una nuova definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, la cosiddetta “rottamazione quinquies”. La ratio è quella di favorire l’adempimento spontaneo, consentendo pagamenti sostenibili nel tempo e riducendo la pressione del contenzioso e delle procedure esecutive.
Parallelamente, la Commissione Finanze del Senato ha avviato un’approfondita indagine conoscitiva sul magazzino fiscale. Nell’ambito di tale attività istruttoria è stata recentemente acquisita la relazione della Commissione Benedetti che ha proposto un’analisi puntuale della composizione del magazzino fiscale, distinguendo tra crediti prescritti, inesigibili e potenzialmente recuperabili, e formulato una serie di proposte operative. Tra queste, di particolare rilievo, l’ipotesi di coinvolgere soggetti privati specializzati (servicer) nella gestione dei portafogli di crediti più datati, con contratti di servizio che prevedano remunerazioni commisurate ai risultati di incasso.
La ratio sottesa all’estensione di tale attività ai soggetti privati consiste nel perseguire l’obiettivo di un più efficace e tempestivo recupero dei crediti erariali, riducendo le perdite per l’erario e migliorando l’equilibrio dei conti pubblici.
Da qui, potrebbe aprirsi una potenziale area di attività molto ampia per gli operatori bancari e i gestori di NPL (soggetti ex art. 106 TUB, 115 TULPS e 114 TUB), grazie alla loro expertise maturata nella gestione e tutela del credito. La partecipazione di tali soggetti, inseriti in un sistema di controllo e verifica delle loro performance, potrebbe dunque rappresentare un valore aggiunto significativo all’attività di riscossione.
Del resto, il connubio tra pubblico e privato è stato già adottato in altri paesi, ad esempio nel Regno Unito, dove il recupero dei crediti governativi è stato centralizzato attraverso un’infrastruttura gestita da operatori privati con supervisione statale.
Dalla lettura delle memorie sino ad oggi depositate, dunque, emerge un generalizzato favor in ordine alla partecipazione di questi operatori all’attività di riscossione, facendo leva su competenze, assetti organizzativi ed approcci ben consolidati.
La relazione Benedetti, tuttavia, invita alla prudenza: un meccanismo che preveda un pagamento anticipato ai servicer sui futuri incassi potrebbe avere «significativi impatti sul debito pubblico» e dare luogo a problemi contabili. Per questo, viene raccomandato di acquisire un parere preventivo da autorità statistiche come Eurostat. Inoltre, affinché l’intervento privato non si traduca in un rischio per l’equità o per la trasparenza della riscossione, la Commissione sottolinea l’esigenza che i servicer operino con garanzia di qualità, tecnologia adeguata e rispetto delle regole procedurali, compresa la tutela dei diritti del contribuente.
Dunque, da un lato, il disegno di legge n. 1375 mira a rendere più accessibili le opzioni di pagamento per il contribuente; dall’altro, l’indagine conoscitiva sul magazzino fiscale suggerisce un nuovo modello di governance per la riscossione, con maggiore efficienza, selezione delle posizioni e partnership pubblico-privato.
Per i professionisti del diritto, del credito e della consulenza tributaria è un momento cruciale: le opportunità di intervento sono notevoli, così come le criticità legate agli aspetti tecnico-operativi e ai rapporti con i soggetti privati incaricati della riscossione.
Resta da vedere se e come il legislatore recepirà queste indicazioni e, in caso affermativo, in che termini il coinvolgimento dei servicer privati sarà regolamentato.
Davvero, dunque l’orizzonte può definirsi tracciato? Ai posteri l’ardua sentenza.

 27.11.2025
27.11.2025

